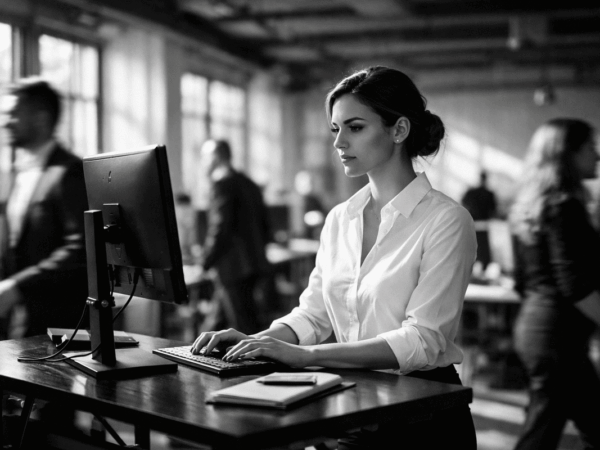Esiste una parola danese che non ha equivalenti in nessun’altra lingua al di fuori della Scandinavia: arbejdsglæde. Si pronuncia all’incirca “ar-baits-glè-de” e significa, letteralmente, “gioia al lavoro“. Non soddisfazione, non engagement, non work-life balance: gioia.
Il fatto che questa parola esista solo nelle lingue nordiche non è una curiosità linguistica. È un indicatore culturale. Quando una società sviluppa un termine specifico per un concetto, quel concetto ha un peso. Viene discusso, misurato, tutelato. In Danimarca l’arbejdsglæde non è un’aspirazione individuale: è un obiettivo collettivo supportato da politiche precise. Le aziende con più di 35 dipendenti sono obbligate per legge ad avere rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di amministrazione. La settimana lavorativa media è di 33 ore. Le ferie sono cinque settimane obbligatorie. Lo straordinario non è valorizzato — è considerato sintomo di inefficienza.
I risultati si vedono nei dati. Secondo Eurofound, il 94% dei lavoratori danesi si dichiara soddisfatto delle proprie condizioni di lavoro, contro una media europea sensibilmente più bassa. La percentuale di lavoratori “attivamente disengaged” — emotivamente disconnessi dal proprio lavoro — è del 10% in Danimarca, contro il 18% negli Stati Uniti secondo Gallup. E il paradosso è che i danesi, lavorando meno ore, sono tra i più produttivi dell’area OCSE.
C’è un contrasto linguistico che illumina questa differenza. Mentre i danesi hanno l’arbejdsglæde, i giapponesi hanno il karoshi: morte da superlavoro. Due parole, due visioni opposte del rapporto tra persona e lavoro. La lingua non solo descrive la realtà — contribuisce a costruirla.
Il precedente italiano
L’Italia non ha una parola per la gioia al lavoro. Ma ha avuto un modello.
Negli anni Cinquanta, mentre l’Europa si ricostruiva e il lavoro industriale significava spesso capannoni anonimi e ritmi alienanti, Adriano Olivetti stava realizzando a Ivrea qualcosa di diverso. Le sue fabbriche non erano contenitori di manodopera. Erano architetture di vetro con vista sulle Alpi, progettate perché — come scrisse lui stesso — “la natura fosse parte della vita della fabbrica piuttosto che esserne esclusa”.
Olivetti introdusse la settimana lavorativa di cinque giorni, primo in Italia. Offrì nove mesi di congedo maternità quando la norma era di poche settimane. Costruì asili nido aziendali, mense dove durante la pausa pranzo si tenevano performance culturali, alloggi per i dipendenti progettati da architetti razionalisti. I salari erano superiori di un terzo rispetto a quelli della FIAT. E tutto questo non per filantropia, ma per strategia industriale: Olivetti era convinto che mettere le persone nelle condizioni di lavorare bene fosse il prerequisito della produttività, non la sua conseguenza.
Il MoMA di New York, nel 1952, definì Olivetti “la principale azienda nel mondo occidentale nel campo del design”. Nel 2018, Ivrea è stata riconosciuta patrimonio UNESCO come “città industriale del XX secolo”. Non un monumento alla nostalgia, ma la prova documentata che un altro modo di concepire il lavoro — e i luoghi del lavoro — è possibile.
Lo spazio come infrastruttura
Quello che Olivetti aveva intuito, e che i danesi hanno codificato in politiche, è un principio che oggi la ricerca sul workplace conferma: lo spazio fisico non è neutro. Influenza il comportamento, la concentrazione, le relazioni, il benessere. Un ufficio con luce naturale, proporzioni studiate, zone per la collaborazione e zone per il focus non è un lusso estetico. È infrastruttura per la performance.
Progetto Design & Build nasce da questa convinzione. La scelta di dotarsi di un reparto interno di Ricerca e Sviluppo — cosa rara nel settore della progettazione workplace — risponde a una domanda precisa: come si progettano spazi che non si limitano a “contenere” le persone, ma le mettono nelle condizioni di esprimersi?
La risposta non può essere solo estetica. Deve essere scientifica. Per questo collaboriamo con università e centri di ricerca, misuriamo gli effetti degli interventi, pubblichiamo i risultati. Il “bello” italiano — quella tradizione di cura per la qualità dello spazio che va da Olivetti al design contemporaneo — non è decorazione. È funzione. È la convinzione, supportata da dati, che la qualità del luogo influenzi la qualità del lavoro.
I danesi hanno inventato una parola per questo. Noi preferiamo progettarlo.